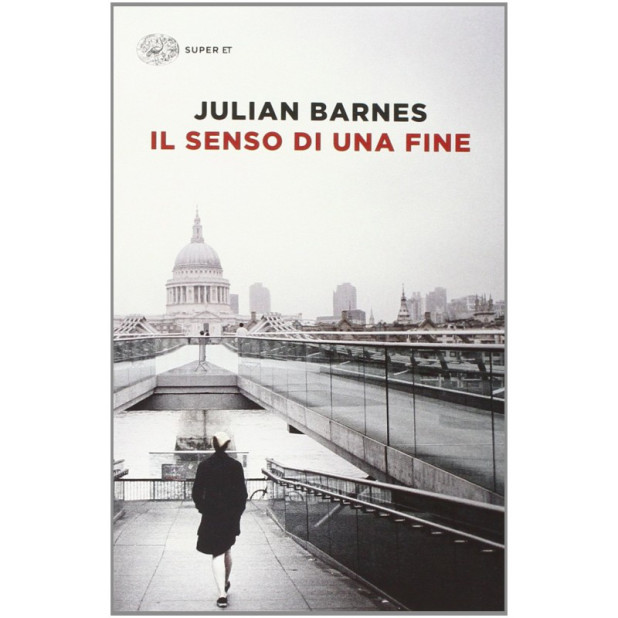“Non sono particolarmente interessato ai miei anni di scuola, non ne ho affatto nostalgia. Ma è a scuola che tutto è cominciato, perciò mi toccherà tornare brevemente su certi eventi marginali ormai assurti a rango di aneddoti, su alcuni ricordi approssimativi che il tempo ha deformato in certezze”. Così afferma Julian Barnes nel romanzo Il senso di una fine, presentandoci i suoi compagni di allora, Colin, Alex, e Adrian Finn, il più brillante intellettualmente, vera stoffa da borsista, che infatti avrebbe studiato filosofia a Cambridge, e con il quale ognuno di loro aspirava a diventare l’amico più stretto. In un’occasione persino il vecchio professore di storia Joe Hunt, beffardo e affabile in giacca e panciotto, gli si era rivolto tra l’ammirato e il faceto: “Finn, io vado in pensione tra cinque anni. Sarò lieto di raccomandarla se volesse prendere il mio posto”.
Chi racconta si chiama Tony Webster, futuro studente di storia a Bristol e in seguito funzionario dei Beni Culturali con una soddisfacente progressione di carriera fino alla pensione. L’epoca in cui è collocata la vicenda abbraccia gli anni Sessanta, definiti favolosi soprattutto da chi non li ha vissuti: “La maggior parte delle persone ha dovuto aspettare gli anni Settanta per vivere gli anni Sessanta”.
E lo scenario non potrebbe essere più familiare a molti di noi:
“Avevamo fame di libri e di sesso, eravamo anarchici e meritocratici. Ogni sistema sociale e politico ci sembrava corrotto (…) Se Alex aveva letto Russell e Wittgenstein, Adrian conosceva Camus e Nietzsche. Io mi ero letto George Orwell e Aldous Huxley; Colin Dostoevskij e Baudelaire. (…) Sì, certo, eravamo presuntuosi, se no a che serve essere giovani? Utilizzavamo espressioni come «Weltanschauung» e «Sturm und Drang»; ci piaceva dire che una cosa era «filosoficamente tautologica», e assicurarci l’un l’altro del fatto che il dovere primario della forza creativa fosse la trasgressione”.
Siamo in Inghilterra, ma in Italia era forse diverso? Abbiamo davanti agli occhi una generazione a carta carbone, scalpitante in quel segmento del secolo scorso in cui il mondo d’un tratto è radicalmente cambiato (in meglio o in peggio chi può dirlo; il principe Talleyrand sosteneva che chi non aveva vissuto negli anni prima della Rivoluzione non poteva capire che cosa fosse la dolcezza del vivere. La douceur de la vie, già; a corte era forse opinione comune, ma il popolo oscuro, il ventre di Parigi di cui scriveranno Zola e Victor Hugo, avrebbe potuto ripetere con altrettanta disinvoltura il medesimo bon mot? Dove si annida la vera verità?
Stringiamo il campo, come si direbbe in gergo cinematografico. Tony, il narratore, conosce all’ università una ragazza che gli piace e che lo ricambia, Veronica Mary Elisabeth Ford: “Studiava spagnolo, amava la poesia. Un metro e sessanta circa, polpacci forti, capelli castano chiaro lunghi fino alle spalle, occhi grigiazzurri dietro un paio di occhiali dalla montatura azzurra, e un sorriso veloce che non ti lasciava più andare”. La ragazza appartiene a un ceto lievemente superiore al suo e sogguarda con qualche supponenza i gusti musicali e letterari del corteggiatore. Ma l’attrazione è reciproca, benché dietro un’apparente disinvoltura le concessioni all’intimità rimanessero millimetriche: “Si sentiva di alcune disposte alla masturbazione reciproca e di altre che ti lasciavano fare «sesso completo», come si diceva allora. (…) Con il progredire del rapporto, si verificava una serie di implicite contrattazioni, alcune fondate sul capriccio, altre su impegni e promesse, fino a ciò che il poeta ha chiamato «la lotta per l’anello». Dopo l’incontro, il ritorno solitario in camera contemplava gloriose “sessioni masturbatorie ispirate a fantasie di lei disponibile e in estasi sopra di me”.
Durante le vacanze lei lo invita per un fine settimana a conoscere i suoi che abitano nel Kent, a Chislehurst. Tony prende il treno a Charing Cross e parte con l’unica valigia che possiede, “così enorme da farmi sembrare un potenziale ladro di appartamenti”. Quando arriva a destinazione, il padre di Veronica caricando la valigia nel bagagliaio dell’auto, commenta scoppiando a ridere: “Hai deciso di trasferirti, giovanotto?”. E entrando in casa replica a voce alta per la famiglia: “Il giovanotto si ferma per un mese.” I Ford abitano in una villetta di mattoni rossi e tetto in coppi, circondata da una fascia di ghiaia. I due giorni insieme a padre, madre e Jack, fratello di Veronica, si rivelano un incubo: “Ero talmente a disagio che mi si bloccò l’intestino per tutto il weekend”. Veronica gli rifiuta persino il bacio della buona notte. La signora Ford, in un momento in cui sono soli in cucina e gli serve di malagrazia le uova con la pancetta, sente il dovere di avvertirlo: “Non dargliele tutte vinte, a Veronica”. Tornando finalmente a Londra il narratore precisa: “Ricordo che mi feci una cacata magistrale”. Successivamente Tony, orgoglioso nondimeno della sua conquista, presenta la ragazza agli amici del gruppo, che mostrano di apprezzarla non poco; Adrian lo schernisce: “Non vorrai le mie congratulazioni, Anthony, spero.”
Trascorrono alcune stagioni: “Veronica ed io continuammo ad uscire per tutto il secondo anno. Una sera che forse era un po’ ubriaca mi concesse di infilarle una mano nelle mutandine. Mi sentii stranamente orgoglioso mentre mi davo da fare come potevo”. Il metodo prescelto è goffo ma efficace. Tuttavia poiché il protagonista non riesce a dare una risposta congrua alla reiterata richiesta della fidanzatina: “A te capita mai di chiederti dove sta andando il nostro rapporto?”, la relazione finisce fatalmente per dissolversi nel nulla. “Dopo esserci lasciati, Veronica venne a letto con me”; due pagine che sono un capolavoro di understatement. Segue la rottura definitiva; i loro reciproci doni finiscono nel negozio dell’usato. Durante le vacanze estive giunge inaspettata da Chislehurst una lettera della madre di Veronica, in cui la signora Ford si dice dispiaciuta della loro separazione, ma senza recriminare nulla; anzi dichiarando a chiare lettere che per lui è senz’altro meglio così, gli augura ogni bene. Impercettibilmente veniamo attratti in un mistero che si infittisce nel corso della narrazione.
Alla ripresa dei corsi arriva una lettera di Adrian in cui l’amico gli chiede il permesso di uscire con Veronica. Il protagonista regge bene il colpo e confessa: “Credo di avere attitudine alla sopravvivenza, all’autoconservazione. Forse è questo che Veronica chiamava codardia e io definivo essere pacifici”. Infatti affida a una cartolina illustrata (il Ponte sospeso di Clifton, immagine carica di presentimenti) una breve, quasi allegra, risposta di circostanza.
La vita va avanti. Il protagonista si laurea, trascorre sei mesi negli Stati Uniti per un viaggio di formazione, ritorna in patria: “Disfeci i bagagli, ripresi possesso della stanza, raccontai qualcosa del viaggio, mi riabituai alla routine, agli odori, ai piccoli piaceri e all’immensa noia”. Ma ad attenderlo c’è la notizia ferale: Adrian è morto, si è ammazzato nella sua camera di dottorando, tagliandosi i polsi nella vasca da bagno. Gli amici naturalmente ne restano sconvolti, definiscono il gesto “un suicidio a pieni voti”, in linea con ogni azione della breve e severa vita dell’amico. Si incontrano per parlarne e concludono che a condurlo a quella fine deve essere stato un atto di estrema coerenza con il suo rigore esistenziale: “L’avremmo ricordato per tutta la vita, ovviamente. Ma la sua morte si configurava più come esemplare che «tragica» – a differenza da quanto sostenuto sul giornale di Cambridge”.
Anthony Webster si impiega presso l’amministrazione per i Beni Culturali, trova un’altra ragazza, Margaret, con cui si sposa e mette al mondo la figlia adorata Susy. Tra alterne vicende e qualche amarezza approda alle rive di una dignitosa vecchiaia: “Il matrimonio è un pranzo interminabile in cui il dolce viene servito per primo”. Tuttavia nel frattempo accade qualcosa di impredicibile, di assolutamente inimmaginabile, che sovvertirà con un clamoroso capitombolo a ritroso l’intera visione della sua esistenza e della stessa realtà: “All’improvviso mi sembra che una delle differenze tra la gioventù e la vecchiaia potrebbe essere questa: da giovani ci inventiamo un futuro diverso per noi stessi; da vecchi un passato diverso per gli altri”.
Siamo ormai nella seconda metà del romanzo, di cui la prima parte è quasi un prologo, un astuto trabocchetto in cui attirare il lettore al fine di sconvolgergli ogni certezza: “La nostra vita non è la nostra vita ma solo la storia che ne abbiamo raccontato. Agli altri, ma soprattutto a noi stessi”.
Leggere vuol dire molte cose, ed è quasi sempre un nutrimento indispensabile. Ma quando dietro le righe che divoriamo con gli occhi c’è uno scrittore del talento di Julian Barnes, capita di sfiorare fenomeni di levitazione, estasi da grazia ricevuta. Le pagine di Il senso di una fine, appena centocinquanta, sono in grado di risarcirci in un’unica dose ricostituente di tutte le letture inutili affrontate a cuor leggero. Attraverso una storia apparentemente ordinaria ma tessuta con fili sottilissimi su un telaio di precisione, lo scrittore ci propone la rappresentazione inconfutabile di noi stessi. Ci distilla un elisir allucinatorio di pura felicità; come sempre capita scalando le sublimi vette dell’arte. Dove anche un’unica frase possiede il potere di scatenare irrefrenabili applausi del cuore: “Detesto il modo che hanno gli inglesi di non prendere sul serio tutto ciò che prendono sul serio”.