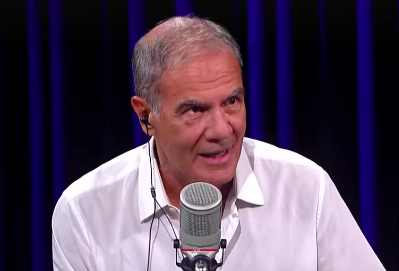Uscire dal mondo (Rizzoli, 2022), l’ultimo libro di Edoardo Albinati, raccoglie tre racconti sull’isolamento, imposto o meno che sia: carcere, malattia, insofferenza verso la mondanità. C’è il desiderio e la fatica del vivere per gli altri e senza gli altri, dentro e fuori l’ingranaggio del mondo; c’è la consapevolezza che non si potrebbe sopravvivere senza “solidarietà biologica”, eppure forte è la pulsione di astrarsene. Ci sono il racconto contemporaneo, il mito, il cinema. C’è l’ondeggiare costante tra identità e alterità.
Uscire dal mondo è uno tra i libri più sorprendenti di Edoardo Albinati. È un difficile incastro di strutture narrative differenti e storie umanissime. Oscillando tra mistico e diabolico, ideale e carnale, disperazione e ironia, in Uscire dal mondo le molteplici nature umane si riverberano in una Babele di storie e sotto storie, personaggi primari e comprimari che sommano e sottraggono sentimenti privati e comuni. Chi alla ricerca di una solitudine ideale, chi costretto a una vita chiusa. Tutti a fare i conti con la propria natura sociale e a-sociale. Ma il libro si rivela spiazzante anche per la già nota caratteristica di Albinati di sfuggire a ogni definizione autoriale che lo imbrigli in uno stile o in un filone narrativo. L’inquietudine dello scrittore si incarna nella ricerca linguistica multiforme: qualcosa di precisamente individuabile, ma che in realtà sfugge a qualsiasi thopos codificato.
L’intervista che segue, entrando nelle vite dei personaggi del libro, mette a nudo le contraddizioni nostre, in cerca e in fuga nel mondo.
Lei riesce a uscire dal mondo?
Credo che ciascuno di noi, in forme diverse, sia dentro e fuori il mondo. Per quanto mi riguarda, non intendo né riuscirei comunque a uscirne. In quanto scrittore, poi, ci sono immerso ma al tempo stesso ne resto fuori: vivo e agisco nel mondo ma ancora di più ne sono osservatore. Infine c’è il carattere, la propensione naturale: mi sono sottoposto a un test dell’Università della California di Los Angeles (UCLA), riportato in un suo libro dal neuroscienziato John Cacioppo, che serve a misurare il senso della solitudine, cioè quanto noi ci sentiamo isolati o incompresi, anche se magari non lo siamo oggettivamente. Un risultato tra i 20 e 40 punti rivela una solitudine media e accettabile, un punteggio più elevato segnala una situazione patologica. Be’, io ho ottenuto 56 punti! Dunque, malgrado io abbia affetti, figli, un lavoro, relazioni varie eccetera, evidentemente mi sento solo. Vorrei essere accettato e al tempo stesso sento il bisogno di scappare via, A parte i casi estremi di persone ostracizzate ed emarginate dalla società, o che per scelta si isolano in eremi, conventi, luoghi scelti per restare davvero soli, credo che un po’ tutti noi viviamo, contemporaneamente, una condizione in cui desideriamo fortemente l’altro, abbiamo bisogno che l’altro abbia bisogno di noi, epperò da questi stessi vincoli vorremmo fuggire. Ho sperimentato insomma che la solitudine non è soltanto qualcosa di oggettivo, ma è un vero e proprio sentimento, per il quale si può soffrire mentalmente ma direi ancora di più fisicamente. La definizione classica, aristotelica, dell’uomo come “animale sociale”, è certamente vera, e però forse incompleta: l’essere umano è alla ricerca continua dell’altro, ma anche desideroso di indipendenza e separatezza; il cosidetto “prossimo” rappresenta una necessità, un desiderio e una minaccia incombente. Il rapporto dell’uomo con il mondo (tenuto conto che il “mondo” si estende ben al di là di quello segnato dalla presenza umana), è dunque in eterna oscillazione. Si tratta di accesso e chiusura: Hegel diceva che si è finalmente adulti quando si entra “nell’ingranaggio del mondo”, ma da quel momento, aggiungo io, nasce anche il desiderio di volersi liberare da quell’ingranaggio.
“La cooperazione vince sulla solitudine, esiste una solidarietà biologica, più che morale”. Questo lo dice sempre Cacioppo (lo ha citato lei, nel suo intervento sul tema “Solitudine e Segregazione” al Festival della Mente di Mantova nel settembre scorso). Ci spiega cosa intende lei per “solidarietà biologica”?
 La “solidarietà biologica” è un retaggio umano arcaico incancellabile. Lo stesso Cacioppo chiama in causa il “terrore genetico della solitudine”: sappiamo per certo che una persona sola, in situazioni di emergenza o povertà, ha inevitabilmente minori possibilità di sopravvivere rispetto a una persona che sola non è, perché fa parte di una comunità. Per questo il sentimento della solitudine può provocare una profonda e insopportabile disperazione. Se ogni essere umano fosse davvero autosufficiente, la solitudine non provocherebbe la paura e il dolore che invece provoca. Esiste quindi un istinto ad aggregarsi agli altri, per avere effettivamente maggiori possibilità di sopravvivere. Ho visto coi miei occhi luoghi del mondo devastati da guerre, carestie, deprivazioni fortissime: se qualcuno riesce comunque ad affrontarle e superarle è perché ha creato intorno a sé una rete sociale di soccorso, una comunità in grado di proteggere chi ne fa parte, nella cooperazione e nella condivisione. E però, quelle stesse comunità, rafforzandosi col tempo, creano strutture e impongono regole che sono per forza di cose limitanti per la libertà individuale. Non ci si sottomette così facilmente alle norme sociali. Da qui, il desiderio di fuggire, di abbandonare rapporti soffocanti e insinceri. La comunità che ci protegge è la stessa che ci vincola e che crea un’infinita frustrazione. Gli altri sono salvifici e al tempo stesso minaccioso. Questa doppiezza mi pare sia presente in tutti e tre i racconti del mio libro. Rileggendolo e correggendolo per pubblicarlo, mi sono reso conto che a vivere una qualche forma di isolamento non sono solamente i protagonisti, ma anche tutti i personaggi secondari: in un modo o in altro, ciascuno sta vivendo o si ritiene vittima di una qualche dolorosa forma di esclusione.
La “solidarietà biologica” è un retaggio umano arcaico incancellabile. Lo stesso Cacioppo chiama in causa il “terrore genetico della solitudine”: sappiamo per certo che una persona sola, in situazioni di emergenza o povertà, ha inevitabilmente minori possibilità di sopravvivere rispetto a una persona che sola non è, perché fa parte di una comunità. Per questo il sentimento della solitudine può provocare una profonda e insopportabile disperazione. Se ogni essere umano fosse davvero autosufficiente, la solitudine non provocherebbe la paura e il dolore che invece provoca. Esiste quindi un istinto ad aggregarsi agli altri, per avere effettivamente maggiori possibilità di sopravvivere. Ho visto coi miei occhi luoghi del mondo devastati da guerre, carestie, deprivazioni fortissime: se qualcuno riesce comunque ad affrontarle e superarle è perché ha creato intorno a sé una rete sociale di soccorso, una comunità in grado di proteggere chi ne fa parte, nella cooperazione e nella condivisione. E però, quelle stesse comunità, rafforzandosi col tempo, creano strutture e impongono regole che sono per forza di cose limitanti per la libertà individuale. Non ci si sottomette così facilmente alle norme sociali. Da qui, il desiderio di fuggire, di abbandonare rapporti soffocanti e insinceri. La comunità che ci protegge è la stessa che ci vincola e che crea un’infinita frustrazione. Gli altri sono salvifici e al tempo stesso minaccioso. Questa doppiezza mi pare sia presente in tutti e tre i racconti del mio libro. Rileggendolo e correggendolo per pubblicarlo, mi sono reso conto che a vivere una qualche forma di isolamento non sono solamente i protagonisti, ma anche tutti i personaggi secondari: in un modo o in altro, ciascuno sta vivendo o si ritiene vittima di una qualche dolorosa forma di esclusione.
Cominciamo, dunque, con il primo racconto: Ragazzo A. Sin dal titolo, emerge una volontà precisa, da parte sua: negare un nome proprio al protagonista per renderlo una personificazione dell’idea, per lo più confusa e distratta che abbiamo fuori, del “carcerato”, inteso come parte di un’intera comunità di persone che delinquono e che vengono relegate nella solitudine della galera.
Già. Ci si potrebbe chiedere come mai non abbia dato un nome proprio al mio personaggio. Comunque, un Ragazzo A ce l’ho avuto davvero tra i miei studenti a Rebibbia, qualche anno fa, è senz’altro lui il modello, bizzarro e stralunato, però posso dire di aver conosciuto moltissimi altri ragazzi “come” lui, insegnando in carcere da quasi trent’anni. Ecco, forse il racconto si sarebbe intitolare semplicemente Ragazzo. Quella lettera A sta indicare qualcosa di primario, di elementare, una specie di grado zero della vita umana. E poi si tratta nient’altro che la traduzione di un famoso disco dei Radiohead, Kid A.
Le tante solitudini, qui, rappresentano bene l’idea di “esclusione” alla quale accennava: Ragazzo A è in carcere, ha un passato familiare drammatico, esprime diverse forme di malattia mentale, è drogato, aggressivo, escluso. Ed esclusi sono anche gli altri personaggi: la professoressa di matematica (ha dedicato la vita a insegnare nel carcere, assiste da sola una madre vecchia e sola, ha poche prospettive di socializzazione); la guardia penitenziaria (vive in casa della madre dopo un matrimonio fallimentare; ha un passato non esattamente limpido; ottiene qualche forma di condivisione del piacere fisico ricattandolo); il trans (ama, odia, protegge, sacrifica se stessa per il bene di Ragazzo A e ha una comprensione della realtà più ampia rispetto a tutti gli altri personaggi).
La professoressa di matematica è una donna forte, che conosce il carcere e i suoi abitanti. È una persona navigata che pensa di non aver bisogno di compensazioni alla propria solitudine, tantomeno “adottando” un giovane difficile come Ragazzo A. ll ruolo del professore in carcere è già di per sé molto particolare: ogni giorno, spesso più volte al giorno, possono verificarsi momenti di “crisi”, diciamo così, della vocazione, del suo senso e della sua efficacia. Chi entra lì ogni giorno per insegnare le materie scolastiche, deve trovare il modo per entrare in risonanza con le vibrazioni fluttuanti e con gli umori sempre in bilico dei suoi studenti carcerati. Se però la condivisione empatica si fa eccessiva, la funzione dell’insegnamento rischia di venire meno. Accade lo stesso che al cosidetto “medico pietoso”: per curare il paziente devi stargli vicino, ma dovresti anche saper essere distaccato. Se empatizzi troppo, finisci per ammalarti tu stesso invece che guarire l’altro. Comunque, è ovvio che la professoressa di matematica “c’est moi!” (Albinati ride). Rischia sul serio di provare una specie di “infatuazione” verso Ragazzo A, mentre non vorrebbe sentirsi così coinvolta da lui. Ecco che qui emerge prepotentemente il tema dell’empatia e del distacco. I guai altrui, ecco tutto, siamo contemporaneamente pronti e quasi ansiosi di prendercene carico, ma vorremmo anche schivarli e allontanarcene. In professioni così delicate come quelle di chi insegna in generale si è sempre alla ricerca di un qualche equilibrio. Fino a che le cose filano lisce, la professoressa di matematica è perfettamente in grado di mantenere il suo “ruolo” e sa gestire anche le difficoltà. Ma nel momento decisivo e drammatico, la barriera del distacco crolla.
Parliamo della guardia penitenziaria: è un personaggio complesso, quasi “luciferino” (ma sono molti i personaggi diabolici, nel libro), ha un ruolo di potere su Ragazzo A (non solo lo sorveglia, ma è anche il suo spacciatore). Prova una sorta di invidia, di gelosia, verso il ragazzo, allo stesso tempo, sente una forma di pena, crede sinceramente di essere il carnefice e il salvatore del protagonista del racconto. Come tutti i personaggi di questo libro, è pieno di contraddizioni.
Nel caso dell’agente penitenziario, sarei felice ne venisse riconosciuta l’ambiguità, che poi nient’altro è che la complessità insita in ciascuno di noi. Questa guardia penitenziaria è sì cinica, profittatrice, quasi sadica, ma è anche sinceramente legata a Ragazzo A, e persino il fatto di rifornirlo di droga, paradossalmente, lui la sente come una forma di solidarietà, di soccorso: Ragazzo A, senza le dosi che la guardia gli procura, avrebbe crisi di astinenza continue, in una mente già compromessa dagli abusi. Julius, cioè, è sinceramente convinto di essere un uomo onesto e buono. In più, esiste un particolare stato emotivo che caratterizza l’intera categoria degli agenti carcerari. Questi si ritrovano in galera (per quanto temporaneamente) senza però essere colpevoli, cioè, detenuti senza aver commesso reati. Per giunta (ed è qui l’invidia a cui lei fa riferimento), i carcerati talvolta instaurano rapporti nuovi, di fiducia, empatia e intimità con gli esterni, quelli che vengono in carcere da fuori, come ad esempio i loro professori. Rapporti da cui gli agenti invece restano tagliati fuori, come dai sentimenti più calorosi e più intimi che si possono sprigionare tra i detenuti e gli esterni. È una forma di frustrazione, la loro, molto profonda e comune. Tornando alla sua domanda, comunque, in tutti i libri che ho scritto e scrivo, cerco di dar vita a personaggi non monolitici, che lascino a chi legge il dubbio se si tratti di persone giuste o ingiuste. Qui, l’agente è cattivo eppure pietoso; Ragazzo A è insopportabile ma angelico; l’insegnante di matematica distaccata e professionale, e però forse innamorata dei suoi studenti. Insomma, nella mia scrittura cerco di non raccontare mai dei cliché. I libri raccontano le molteplicità della natura umana, ma questa molteplicità è anche interna a ciascun personaggio.
Insomma così come siamo soli pur senza esserlo, siamo anche cattivi e buoni, ambigui ed espliciti. E questa è la premessa per introdurre l’ultimo personaggio del primo racconto: il trans.
Certamente, in ogni personaggio è rappresentata la complessità della natura umana. Allora un transessuale, da un punto di vista squisitamente narrativo, è il personaggio ideale per rappresentare e contenerne in sé l’intero spettro: carattere, umori, atteggiamenti, esperienze. Le vicende umane, quasi tutte, sono controverse. Non vi sarebbe sviluppo senza controversia, nella vita così come nei racconti e nei romanzi. Nelle persone transessuali, questa complessità mi pare si manifesti in modo, per così dire, plastico, prima di tutto nel loro corpo. E non è un giudizio di merito, ma una semplice riflessione. Descrivendo Cynthia, mi sono ritrovato a fare l’unica considerazione personale dell’intero libro: ragionando sul fatto che i trans sarebbero perfetti per ricoprire ruoli istituzionali in quanto hanno attraversato da un capo all’altro la natura umana, la conoscono e rappresentano bene da ogni lato la si voglia guardare. Mi sono permesso questa notazione, al tempo stesso ironica e però molto seria, senza starmi a preoccupare qualcuno potesse leggerla come un giudizio sconveniente. Voglio dire, Cynthia, un po’ come Tiresia, ha un’ampiezza di sguardo sul mondo che nasce evidentemente dalla sua sessualità multipla. Il che comprende una infinita gamma di sentimenti contrastanti che possono confondere chi li vive, o illuminarlo con una speciale saggezza. La varietà rende più capaci di prendere in considerazione ciò che gli altri nemmeno vedono, di cui non si accorgono, con una completezza e un grado di accettazione umana superiore. Con il redattore di Rizzoli abbiamo poi avuto delle interessante e attualissime discussioni sull’impiego dei generi grammaticali, dato che io, esattamente come si usa dire in carcere, definivo quelli come Cynthia “i trans”, al maschile, chiusi appunto nel reparto “dei trans”, visto anche che anagraficamente risultano tali e proprio per questo sono rinchiusi in un carcere solo maschile; ma poi nel resto del racconto parlando di Cynthia usavo il femminile negli articoli, aggettivi e pronomi, riferendomi a lei appunto come a una “lei”: e quindi era bella, si sentì turbata, le sembrò di capire, eccetera. Be’ alla fine io ho preferito mantenere questa incongruenza grammaticale perché aderisce di più alla realtà delle cose. Un conto è il linguaggio formale e burocratico, un altro quello naturale e letterario. Nessuno in galera parlerebbe di loro come “persone transessuali”, sono “i trans” e basta. Così come lo scellerato mendicante di cui Lazarillo de Tormes diventa servo, proprio all’inizio di quel meraviglioso racconto, bisogna dire che è cieco, non c’è altro modo di dirlo, un mendicante cieco, semplice, no? Non arrivo a immaginarlo come “non-vedente” o “portatore di handicap visivo”.
Arriviamo al secondo racconto, La ragazza strana. Il personaggio più “luciferino” dell’intero romanzo è qui: Padre Alighiero. Questo prete ama le donne, anche in modo violento; è inquieto, colto, dolorante, riesce a fare un’omelia sullo “stupore del vivere” profondamente coinvolgente, è un uomo anche di chiesa: sta nel mondo carnalmente, miseramente, ma rispetta e segue la propria missione, con una fede sincera e una conoscenza reale delle cose, dentro una comunità di paese, dove accadono cose strane, paesane. Insomma, questo prete che sta dentro e fuori dal mondo, chi è?
Il prete mi sembrava la figura classica dello stare dentro le cose del mondo, mantenendosene comunque lontano: immanente e trascendente, insomma. Padre Alighiero, nella comunità cittadina in cui vive, è stato per molto tempo visto come un santuomo, un profeta, una vera guida spirituale. Nel momento in cui la comunità viene a scoprire che il supposto santo si è reso responsabile di molestie e atti osceni nei confronti delle sue parrocchiane, ecco che perde la sua aureola, precipita nell’infamia alimentata dalle dicerie, rischiando persino il linciaggio. Riuscirà in un modo o nell’altro a discolparsi e redimersi? L’altro fattore che sta turbando la quiete di quella cittadina è il caso di una ragazza, Giglia, che è stata colpita da un male misterioso, un fiume inarrestabile di lacrime corrosive che l’hanno sfigurata e costretta a non uscire più. Chi riuscirà a guarirla? Tornando a Padre Alighiero: così come ne La scuola cattolica, neanche qui ho avuto la pretesa di attaccare e smascherare i preti lussuriosi o la Chiesa corrotta (chi vuole denunciare, vada dai Carabinieri, è il posto giusto, oppure, se intende comunque scriverne, meglio che faccia inchieste invece che romanzi). Normalmente non mi pongo obiettivi polemici, in questo libro meno che mai. Ho piuttosto cercato di seguire uno schema narrativo che avesse la sua radice nel mito. E cioè che a guarire una ferita così misteriosa e grave come quella di Giglia, sia lo stesso personaggio che quella ferita ha provocato. Questo racconta il mito di Télefo, figlio di Ercole: ferito dalla lancia di Achille nella coscia, solo dal tocco di quella stessa lancia potrà essere guarito. Ecco il mito: chi causa un danno è chiamato a ripararlo, solo lui e nessun altro potrà riuscirci. Che pensiero vertiginoso! Nel mio racconto, chi ha causato la malattia di Giglia, sia pure indirettamente, solo lui potrà curarla. Il male interiore si manifesta attraverso il corpo della ragazza, con quel pianto acido ininterrotto che le sta ustionando il viso. Ma il responsabile del male non è soltanto chi lo ha commesso, bensì la comunità tutta: è come se l’intero paese sia al tempo stesso causa e vittima del medesimo dolore che affligge la ragazza. Il male ha il potere di contaminare chi lo commette, ma anche chi lo subisce. Per purificarlo occorre che il responsabile partecipi alla purificazione insieme alla vittima. Ma tutte queste sono considerazioni che sto facendo adesso, a posteriori, a libro pubblicato: sono pensieri secondari, mentre il nucleo iniziale di un racconto è costituito a partire da una situazione e da alcuni caratteri che la animano. A raccontare la storia stavolta è il paese intero, una voce collettiva che parla, pensa, afferma, nega, spettegola; ha una funzione simile a quella del coro nel dramma classico; si esprime dunque attraverso una prima persona plurale. Nel giudicare la condotta di Padre Alighiero questo “Noi” capace di giudicare, criticare, ipotizzare, malignare, non può che dividersi in opposti schieramenti, colpevolisti e innocentisti, che però possono cambiare idea in base a nuovi elementi, anche minimi, oppure per nessuna ragione, l’opinione pubblica è così volubile, volatile… Alla fine, che questo prete sia un santo o davvero un porco, lo si potrà sapere solo quando un tribunale lo stabilirà; ma questo processo avverrà quando il mio racconto è oramai terminato, rimane fuori dalla storia, come un’ipotesi. Probabilmente la comunità del paese continuerà a dibattere anche dopo la sentenza. E poi ci sono gli altri personaggi della storia: c’è il farmacista Fanelli, iperrazionalista, fanatico anticlericale, un essere istrionico eppure timido e solitario; la madre di Giglia, Carmen, misteriosa e riservatissima, di cui nessuno conosce la vita sentimentale; e c’è ancora la migliore amica di Giglia, Venturina, la quale riesce a inventarsi una qualche vita sociale solo camuffandosi, mascherandosi da cartone animato giapponese, come fanno i cosidetti cosplay, quindi riesce a essere se stessa solo quando, in effetti, cessa di esserlo…
E il personaggio del farmacista Fanelli siamo noi, un’intera comunità che parla per una voce sola?
Ho preso a modello monsieur Homais, il farmacista di Madame Bovary. Così come Padre Alighiero, Fanelli ha in cura la sua comunità. Vendendo medicamenti (e quindi con uno spirito pratico, di commerciante) procura strumenti per la guarigione. È l’equivalente laico di Padre Alighiero, e il suo contraltare. Il conflitto non solo divide i due contendenti, ma contribuisce anche a unirli: le due parti del contrasto, in modo vertiginoso, possono somigliarsi molto tra loro, in una specie di simmetria. Queste notazioni, che potrebbero sembrare di carattere sociologico, per me sono principalmente di carattere letterario: scrivendo si obbedisce a degli schemi molro antico, magari rivisitandoli. Avere un doppio, un alter ego, secondo me è inevitabile, e in una storia di finzione lo è ancora di più. Se Padre Alighiero è diabolico e divino insieme, dall’altra parte ci dovrà essere uno scettico, razionalista e miscredente come Fanelli.
Mi pare che la protagonista di questo racconto, Giglia, ne sia il personaggio più misterioso.
Giglia è l’agnello sacrificale del racconto. Non è semplicemente il terreno di scontro della narrazione: questo personaggio si rivela capace di una serenità e di un’accettazione del dolore che hanno qualcosa di sovrumano. Forse è una Santa, e non a caso è adolescente, come nella agiografia di molte sante. Giglia resite a questa malattia della quale sa benissimo di non essere responsabile. Non è certo lei l’origine del male, ma in lei la malattia si manifesta, ed è lei a sopportarla. È innocente, eppure si prende carico della pena. In una versione visiva di questo racconto sarebbe molto importante trovare un’interprete che rappresenti tenerezza e innocenza assolute, perché questa è la “stranezza” di Giglia, che resta per tutti un mistero: non si sa chi sia il padre, ha una madre taciturna e riservatissima, lei stessa parla pochissimo. E’ venuta al mondo misteriosamente e porta su di sé il dolore come un peso al modo di Cristo, cioè il dolore del mondo intero, per così dire. Se Giglia è una figura mistica, vorrei ricordare che la mistica è qualcosa di molto fisico: l’iconografia dei santi rappresenta i loro corpi lacerati, le ferite inflitte dagli uomini o da Dio. Il termine mistico in altre parole non è affatto equivalente a disincarnato, anzi. La figura che ho disegnato è quella di una ragazza non particolarmente bella, con le labbra sottili, per nulla avvenente. E questo contrasta con la bellezza esplicita, carnale, prorompente di sua madre Carmen. Questa non-bellezza della ragazza la rende pura, ma vorrei dirlo meglio: la rende “neutra”. Per questa sua neutralità capisco che possa sembrare un personaggio meno risolto di altri, ma questo si deve al fatto che Giglia è una pura linea, un “disegno”, a puntasecca, diversamente del corpo “a olio” della madre.
Oubliette, il terzo e ultimo racconto, è costruito in modo sorprendente, dal punto di vista strutturale e contenutistico. Molti lo hanno paragonato a un flusso di coscienza, ma potrebbe anche sembrare qualcosa di simile alla “scrittura automatica”. Personalmente, credo che la forma narrativa che ha adottato nulla abbia a che fare né con l’una né con l’altra struttura. Mi pare sia una personalissima, solitaria, intima ricerca della lingua, nella quale gli incisi e quelle virgole che cercano di dare un po’ di respiro al lettore, si rincorrono in una narrazione estremamente complessa. Vorrei rimarcare la solitaria ricerca dello scrittore Albinati, un esercizio di stile. Un esercizio di precisione, formale e contenutistico dell’autore, il quale emerge ma non invade il personaggio.
Questa modalità, o se vogliamo questo stile, è unico, irripetibile e la sua durata non poteva essere più estesa di così. Per analogia col linguaggio del cinema, potrei dire che è un “piano-sequenza”, che crea un’unica scena senza stacchi fino alla fine. Non potevo scrivere questa storia diversamente da così. Pensavo che l’affanno insopportabile di quest’uomo – si è chiuso nella sua splendida casa veneziana, con l’unica compagnia di un cane spelacchiato, sente di essere giunto a un punto morto della propria vita, dove gli amori, la musica, gli incontri, non hanno più alcun senso – si potesse manifestare solo attraverso questa precisa struttura narrativa, in grado di rendere la sua esigenza, appunto, di “uscire dal mondo”. L’amore per la musica (è un affermato compositore), l’amore per gli amici, per il cibo, per il bere, per i piaceri della vita si sono esauriti completamente in lui. Egli è, appunto, in affanno. E l’affanno non potevo che scriverlo così: in modo irresistibile. La difficoltà tecnica è stata proprio quella di trovare la sintassi più snodata possibile, ma senza ricorrere a espedienti. Inoltre, non potevo completare questo racconto “senza fiato” se non costruendo l’evento sociale per eccellenza: un ricevimento, nel giorno della Festa del Redentore di metà luglio. Il nostro musicista deve e capire se dare o non dare questa festa, il che significa organizzarla, cucinare, curarsi di tutti e di ciascun ospite, nel migliore dei modi possibili, come lui ha sempre fatto in passato, per altro. Ora, all’improvviso, non ne ha più voglia. Anzi ne ha quasi paura, e la sua paura si materializza in una fissazione: l’eventualità che il ghiaccio con cui raffreddare i cocktail possa non bastare. Orrore, che i suoi ospiti bevano bibite tiepide e dunque ne siano scontenti! Per buona parte del racconto, questo pensiero insopportabile ritorna, ciclicamente, costantemente. Esattamente come tutte le forme ossessive: cicliche, martellanti. Ecco, al di fuori di questa struttura narrativa, non avrei saputo come raccontare i sentimenti di questo personaggio. Probabilmente non la userò mai più, in futuro, ogni storia deve trovare la sua voce particolare. Del resto a me non interessa avere una cifra inconfondibile, cioè, la firma, la riconoscibilità stilistica assoluta come scrittore.
Questo personaggio, nevrotico, incastrato dentro di sé, che soluzione trova? Se davvero si vuole alienare dalla chiacchiera, dall’equivoco e dal pettegolezzo dell’essere nel mondo heideggeriano, trova, in sé, una soluzione per continuare a vivere? La solitudine di quest’uomo, per altro, è tutta autoindotta: non c’è il carcere, non c’è la malattia, non c’è costrizione alcuna. La sua è una scelta.
Non credo si risolva. È tutto contraddittorio in questo personaggio, a partire dal desiderio di isolarsi dal mondo: lo vuole davvero? Ne è così sicuro? No, non credo che quest’uomo si risolverà. Credo, invece, che ci rappresenti un po’ tutti: ciascuno di noi, arrivato a un certo punto della propria vita, vorrebbe dire: “Basta! Non ne posso più! Non voglio più rispondere al telefono, non voglio più andare dal commercialista. Non voglio più cenare fuori, uscire, stare in mezzo al traffico. Soprattutto, non ho più niente da dirvi, oltre che da darvi!”. Sono dell’idea che chi voglia realmente uscire dal mondo, in qualche modo debba averlo prima attraversato. Ecco, quest’uomo senz’altro lo ha attraversato: ha viaggiato, la sua musica è stata eseguita in tutti più grandi teatri del mondo, ha conosciuto persone e avuto amori, insomma, ha fatto tutto. E non è vecchissimo, tutt’altro. Epperò è stanco e, più che chiedere di essere lasciato pace dagli altri, lo chiede a se stesso. Non c’è un’età giusta per essere stanchi. Quest’uomo, un po’ come molti di noi, non vuole mica morire, vorrebbe solo essere lasciato in pace. Anche perché gli ho affibbiato le rogne più detestabili del nostro essere nel mondo: gli accertamenti fiscali, i danni dell’acqua alta, l’amico odioso che gli fa causa per dei vecchi mobili ammuffiti…. Insomma, la solitudine può essere anche una legittima aspirazione, non solo una condanna.
ìUn’ultima, inevitabile, domanda. A noi che ci riteniamo “i buoni” della società italiana e che non abbiamo votato per la Destra, alle recenti elezioni politiche, conviene Uscire dal mondo, ora?
Be’, io in verità non ho votato… E comunque, il titolo di questo libro l’ho tratto dal un libro di Hannah Arendt, L’umanità nei tempi bui. La Arendt scrive: “Ma nemmeno la semplice forza di fuggire e di resistere nella fuga potrà materializzarsi quando la realtà è ignorata o dimenticata; quando l’individuo si ritiene troppo buono, troppo nobile per misurarsi con un mondo simile, o non riesce a fronteggiare la negatività assoluta delle circostanze che dominano in un momento dato”. Insomma: sentirsi al di sopra della realtà non salva l’anima. Il mondo tocca comunque viverlo, in un modo o nell’altro. In fondo ciascuno di noi è il mondo: anche scappando nel deserto ci porteremmo il mondo con noi, il peso di noi stessi. Il proprio io potrebbe essere una compagnia ancora più ingombrante di quanto lo sia quella degli altri…