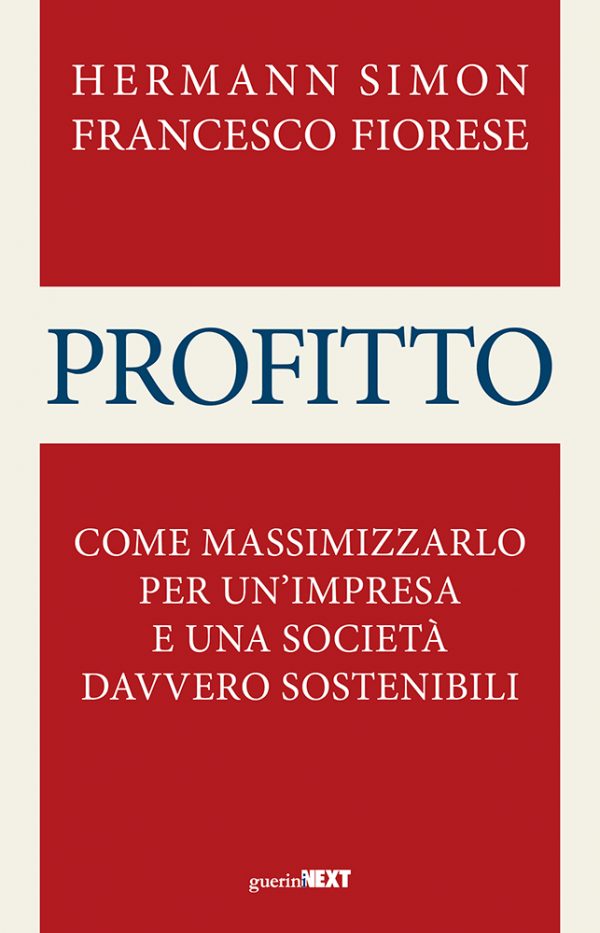È la massimizzazione dei profitti l’obiettivo cui dovrebbero tendere aziende e dirigenti per garantire la sopravvivenza della stessa azienda e servire il benessere non solo dei suoi azionisti ma anche, più in generale, degli stakeholders.
Quando un’impresa ottiene un profitto, di solito ne beneficiano i dipendenti, i partner dell’azienda lungo la catena del valore, le banche, il governo e in definitiva la società nel suo complesso.
Questa è, in sintesi, la tesi sostenuta con passione da Simon e Fiorese. Una determinazione che neanche l’avvento della digitalizzazione sembra poter mettere a rischio. Gli autori si mostrano infatti convinti che, al pari di quanto accaduto per la New Economy, anche la digitalizzazione prima o poi dovrà fare i conti con il profitto.
Circa due decenni dopo lo scoppio della bolla della New Economy, si assiste a una nuova era di euforia in cui l’84 per cento delle aziende che si quotano in borsa non ottengono profitti, ma in alcuni casi godono di valutazioni di mercato ridicolmente alte. Questi sono i reali rischi di sostenibilità temuti ed evidenziati da Simon e Fiorese, non il profitto in sé, se lecito ovviamente, perché esso rappresenta e deve rappresentare il naturale obiettivo di un’azienda sana e prosperosa.
Per le aziende private, non c’è alternativa all’orientamento al profitto. Dopo tutto, nessuna azienda è mai andata in bancarotta per aver guadagnato.
La massimizzazione del profitto – o forse peggio «la massimizzazione del valore per gli azionisti» – è considerata da molti osservatori come la radice di tutti i mali del nostro sistema economico.
Eppure, secondo Simon e Fiorese, nella sua essenza la massimizzazione del profitto è semplicemente l’antitesi dello spreco.
I critici sostengono che la massimizzazione del profitto e del valore per gli azionisti è responsabile dello sfruttamento delle risorse e dei lavoratori, delle disparità di reddito e di patrimonio, della delocalizzazione dei posti di lavoro in paesi a basso salario, del trasferimento delle sedi aziendali in paradisi fiscali e di molti altri abusi.
Ma queste critiche sono, per gli autori, in netto contrasto con le basi teoriche della microeconomia, fermo restando che l’etica è e dovrebbe rimanere la pietra angolare della leadership di lungo termine. Concetto sintetizzato dalle parole del secondo decano della Harvard Business School: «a decent profit decently» (un profitto soddisfacente in modo corretto).
Nella realtà però esistono le zone grigie e allora non ci si può non interrogare su cosa rientra effettivamente nella definizione di decently e cosa no.
Il profitto è la ricompensa che spetta a un’azienda per l’assunzione del rischio imprenditoriale. È ciò che rimane dopo che sono stati pagati gli stipendi, i dipendenti, i fornitori, le banche e altri creditori, oltre alle tasse dovute a governi statali e locali. Il profitto è quindi un residuo legittimo che appartiene solo ed esclusivamente ai proprietari dell’azienda.
Viene da sé comunque che questi imperativi degli autori si riferiscono alle aziende che regolarmente pagano i dipendenti, onorano i propri debiti e versano le tasse e i contributi. Condizione estremamente differente dalle società fittizie che nascondono capitali all’estero, in aree off-shore appositamente per bypassare il fisco.
Vero è anche che una delle leggi fondamentali dell’economia ci dice che profitto e rischio hanno una correlazione positiva. In altre parole, le opportunità di un profitto più elevato comportano un maggior rischio. Si può usare questa legge in una semplice regola pratica per il processo decisionale: per un dato livello di profitto, si dovrebbe scegliere l’alternativa con il rischio più basso. Al contrario, si dovrebbe scegliere l’opzione con il più alto profitto potenziale se i rischi sono uguali. I mercati di capitali però valutano le opportunità di investimento a più alto rischio.
Tutti parlano di un sistema basato sulla meritocrazia ma in realtà vogliono intendere la capacità di fare soldi e di farli fare a loro volta. E chi è esterno a questo meccanismo perverso non può fare a meno di chiedersi se davvero conta solo questo e perché.
Non è solo una questione di soldi. È lo status che risucchia inesorabilmente molti nel «tunnel della dipendenza da lavoro», nel mondo dorato dei bonus milionari, dei viaggi in prima classe e delle vacanze in resort di lusso in località esotiche… un «sistema chiuso che ti allontana ancora di più dalla realtà» e per il quale «vendi l’anima al diavolo. Io l’ho venduta per le ricchezze terrene. In cambio il diavolo ha voluto il mio fallimento morale». Tanti banker nel momento in cui realizzano cosa stanno facendo hanno dei crolli emotivi che cercano di riempire con fiumi di alcol. Ragazzi per la gran parte sotto i trent’anni che non possono parlare tra di loro se non di lavoro, la concorrenza è troppa e la debolezza non è ben vista in quell’ambiente. Non possono parlare con famigliari amici affetti perché chi è estraneo a quel mondo stenta a comprendere e a condividerne le dinamiche. Si ritrovano a vivere le loro interminabili giornate di lavoro in un sistema chiuso dove «l’etica è questa: o sei con noi o contro di noi». Un ambiente “amorale” nel quale lo scopo diffuso è “ingannare” i clienti senza infrangere alcuna legge o norma. Uno dei motti più diffusi tra i banker è “it’s only Opm (Other People’s Money) – è solo denaro altrui”.1
I margini di profitto tendono a essere più bassi nei paesi grandi e viceversa ma, in generale, i margini di profitto netto nei paesi dell’Unione Europea tendono a essere più bassi. Le aliquote fiscali più alte aiutano a spiegare questo fenomeno.
Oltre che da paese a paese, i margini di profitto variano in maniera significativa anche tra i diversi settori industriali. Nelle industrie pro-cicliche – ossia molto legate all’andamento dell’economia in generale – come quella petrolifera e del gas, le fluttuazioni dei prezzi possono avere un forte effetto sui margini di profitto annuali. Al contrario, altri settori come quello farmaceutico, ovvero anti-ciclici, conservano margini elevati sostenuti.
L’industria farmaceutica è seconda, dopo software/entertainment, per margine di profitto.2
I profitti elevati sono moralmente discutibili? Per certo non si può negare che esistono casi delicati e complessi – da un punto di vista etico – soprattutto in settori particolari, tra i quali rientra a pieno titolo l’industria farmaceutica. Farmaci innovativi e salvavita dai costi esorbitanti pongono dure sfide etiche alle aziende e alla società intera.
«Siamo fermamente convinti che le terapie debbano essere pagate in base al loro valore. Siamo determinati a fissare i nostri prezzi secondo questo principio.»3
Si tratta di aziende private. È un loro diritto orientare la politica aziendale al profitto. Ma tutto questo non può non rispolverare l’annosa questione sul concetto di salute pubblica e accessibilità alle cure mediche.
Kymriah, una terapia genetica sviluppata da Novartis, può curare una certa forma di leucemia con una sola iniezione. Negli Stati Uniti, un’applicazione di quel farmaco costa fino a 475mila dollari. Il servizio sanitario britannico ne copre una parte del costo, in determinati casi. In Germania il prezzo è di 320mila euro. Ed è solo uno dei numerosi esempi che si possono riportare e che riguardano tutte le case farmaceutiche, non solo Novartis.
Ovvio che il costo di queste terapie non è dipendente solo dal profitto, in larga parte dal lavoro che ha portato alla sua creazione. Il punto è quanto sia etico che salute e guarigione siano affidate al settore pubblico lecitamente votato al profitto.
Singolare poi, per non dire paradossale, che le industrie farmaceutiche e quelle del tabacco siano così vicine nella classifica dei profitti.
Gli autori sottolineano come la critica all’orientamento al profitto provenga, in gran parte, dagli intellettuali e non solo quelli riconducibili ad ambiti politici di sinistra.
Questi generalmente pensano di essere più intelligenti degli uomini d’affari e, se si prende in considerazione il quoziente intellettivo, questa auto-percezione potrebbe effettivamente essere esatta. Ma guadagnano decisamente di meno e, siccome non imputeranno mai ciò a qualche loro carenza, additano il sistema come responsabile al pari e in correità al comportamento spregiudicato degli stessi uomini d’affari. E anche su questo versante esplorato dagli autori si apre un mondo di interminabili discussioni sul valore da attribuire alla cultura, alla formazione, alle competenze, alla meritocrazia.
«I ricchi sono bravi a guadagnare soldi ma di solito non sono persone decenti (rispettabili).»4
A onor del vero, va ricordato che lo scetticismo verso la filosofia del profitto alberga anche all’interno della stessa comunità degli economisti. Tuttavia gli autori rammentano al lettore che, nel mondo reale, è raro che qualcuno sappia in anticipo quale comportamento consentirà di raggiungere i più alti profitti possibili, o quanto effettivamente alti potrebbero essere i loro utili.
Bisogna infatti sempre tenere presente che un numero considerevole di aziende – presumibilmente più della metà – non genera alcun profitto economico e quindi non recupera i propri costi di capitale.
Nella personale esperienza di Simon e Fiorese, solo pochi imprenditori e manager danno la massima priorità al profitto. A dominare sono invece gli obiettivi di reddito, volume o quota di mercato. Ancora una volta a primeggiare, per orientamento al profitto, sono le aziende farmaceutiche e dell’healthcare in generale.
Sulla questione della discutibilità morale dei profitti gli autori sono perentori: dipende più da come vengono realizzati che dal loro ammontare. Il profitto è il prezzo della sopravvivenza. Se un’azienda non guadagna, prima o poi fallirà.
Simon e Fiorese sono dei tecnici del settori per cui il loro orientamento, anche di scrittura, è economico, non politico né sociale. Tuttavia hanno cercato di mantenere sempre una certa obiettività nell’esporre perlopiù fatti e dati piuttosto che opinioni personali. Molto utile, per i lettori generici, anche la parte iniziale del testo, dove vengono analizzati i vari aspetti della formazione del profitto aziendale e ne vengono indicati anche i copiosi fraintendimenti di senso che si diffondono lungo tutti i canali della comunicazione e dell’informazione.
Un libro la cui tesi si può anche tentare di confutare ma che rimane comunque molto interessante e veritiero.
Il libro
Hermann Simon, Francesco Fiorese, Profitto. Come massimizzarlo per un’impresa e una società davvero sostenibili, Guerini Next, Milano, 2022.
Gli autori
Hermann Simon: fondatori e Honorary Chairman di Simon-Kucher&Partners. Tra i maggiori management thinkers contemporanei, ha insegnato come accademico al MIT, Insead, Harvard, Stanford e London Business School.
Francesco Fiorese: partner dell’ufficio di Milano della Simon-Kucher&Partners. Autore di numerosi articoli e studi dedicati alla strategia e al marketing.