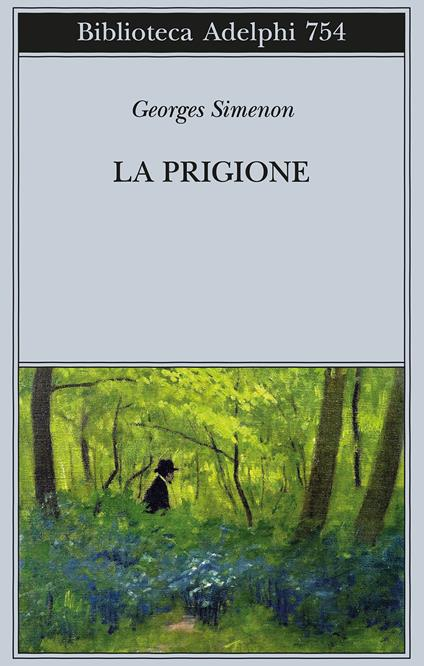Qual è la vera prigione: le sbarre dietro cui ci sospingono gli altri, o la cella in cui ci chiudiamo da soli a doppia mandata senza neppure accorgercene? Simenon questa volta gioca pesante con il lettore, e forse con sé stesso; non prova neppure a costruire un intreccio da sciogliere, una mappa approssimativa da calpestare, si limita ad attrarre il lettore nella corrente della narrazione e tenercelo immerso a testimone di ciò che accade. Già dalla frase di inizio concepita come un trabocchetto esistenziale: “Quanti mesi, quanti anni ci vogliono perché un bambino diventi un ragazzo, e un ragazzo un uomo? Quando si può affermare che la transizione è avvenuta?”
Alain è un giovane di mediocri speranze e, seppur bocciato all’esame di maturità, capace come pochi di destreggiarsi nella giungla metropolitana indossando, senza alcuna regalità, la criniera del leone. Ha fatto soldi, a palate, inventando un rotocalco glamour, provocante e sfacciato, con fresche ragazze in bella mostra e articoletti croccanti, come baguette appena sfornate, adatti alla massa indifferenziata dei lettori di bocca buona e soprattutto delle lettrici. Il settimanale si intitola TOI (TU), lanciato con una campagna martellante e azzeccata, un dito indice puntato perentoriamente sul passante: il quale abbocca sospingendo la tiratura sopra il milione di copie, con le vendite in costante crescita.
Nel pieno dei suoi trent’anni il giovanotto ha conquistato letteralmente Parigi diventando milionario e conducendo una vita da nababbo. Presenzialismo instancabile, perennemente in vista, giorno e notte tra redattori adoranti e riunioni mondane, auto di lusso costosissime, vistoso appartamento in centro e spettacolare residenza di campagna per i fine settimana. Ingurgita whisky a litri, in qualsiasi momento della giornata, cliente a conto aperto di tutti i bar ben frequentati della capitale: “Un doppio signor Alain?” Prima ancora che lui chieda, il bicchiere di scotch è sul bancone, la marca la conoscono. Lui ingurgita come una spugna, da mattina a sera a notte, un vizio di cui è diventato schiavo senza accorgersi, dal momento che regge bene l’alcool e non si ubriaca quasi mai.
A pranzo e a cena ha sempre accanto a sé la giovane moglie Jacqueline, presente come un’ombra a mezzo passo dal suo gomito destro, senza chiedere mai nulla, senza mai lamentarsi o protestare, come fosse una sua protesi, un pet, un animale da compagnia. Lui la chiama Micetta, con la stessa generica leggerezza con cui si rivolge a tutti gli altri usando formule impersonali come cocco mio, o cocca mia, o vecchio mio. Dal matrimonio hanno avuto un figlio, che ha cinque anni e che entrambi vedono assai poco, affidato alle domestiche e alle bambinaie. Il loro appartamento sontuoso si riempie frequentemente di amici, fino a tardissima ora, tra chiacchiere, liquori e pettegolezzi. E la mattina si ricomincia da capo, senza scosse: caffè, croissant e qualche aspirina contro il mal di testa e la bocca impastata. La moglie lavora come giornalista, ma non per la sua testata, freelance dei magazine alla moda; è specializzata in interviste con i personaggi famosi di ogni nazionalità, di cui Parigi è strapiena, e così durante il giorno non si vedono quasi mai. Soltanto scambio di telefonate, sistematiche e frettolose. E lui si ripassa tutte le ragazze che gli vengono a tiro, senza distinzione, anche loro sono tutte cocche; è un bell’uomo, ricco, elegante, ricercato, corteggiato, una vita agiata, la redazione ai suoi piedi, le schiere di finti amici nei bar e nei salotti. Le porte della Ville Lumière sono sempre aperte per lui, dal mondo finanziario alla politica, dalle alte cariche dell’amministrazione ai vertici della polizia. Con le donne non ha che da acconsentire, dove capita, con chi capita: le sue dipendenti, le segretarie, le telefoniste, le modelle che posano per la rivista, nello studio del fotografo Julien Bour, “dall’aria triste e macilenta” ma in grado come pochi di esaltare le poco segrete virtù delle ragazze. Anche le domestiche vanno bene se sotto il grembiule trasparente si mostrano semi nude, meglio se senza mutandine. La sua vita è simile a una pallina da flipper che rimbalza da una sponda all’altra e non ha alcun bisogno di riflessione, di pensiero, di scelte. L’essenziale è non star fermi, non rimanere mai da soli.
I suoi genitori sono persone modeste, rimaste tali e in disparte, fieri di lui, figlio unico, e se non fieri rassegnati: l’hanno lasciato crescere a suo modo e sanno bene che nessun altro tipo di esistenza gli si adatterebbe. Ad Alain Poitaud non manca nulla, tiene il mondo in mano.
Sennonché una sera fredda e piovosa, rientrando a casa, trova ad aspettarlo sotto l’acqua, all’incerto riparo del portone, un ispettore di polizia. Ha una comunicazione molto importante per lui, che non è autorizzato a riferirgli, dovrà seguirlo in centrale al Quai des Orfèvres. E qui il vice commissario Roumagne, “un uomo sulla quarantina, dall’aria stanca” lo mette al corrente senza troppe giravolte: sua moglie Isabelle ha ucciso Adrienne, la sorella più giovane, con un colpo di pistola. Una Browning presa dal cassetto del suo comodino. Un omicidio?! E per cosa, per quale ragione?
Ha inizio un blando interrogatorio, quasi una conversazione confidenziale tra i due, nella quale Alain ammette di essersi portato a letto Adrienne, anzi Bimba secondo uno dei suoi nomignoli. Quante volte? Una lunga relazione, voluta principalmente da lei, incontri consumati “in un monolocale ammobiliato, in Rue Longchamp…” Per anni si erano visti a scadenze regolari, ma la relazione era terminata, da prima dell’ultimo Natale, erano trascorsi ormai più di dodici mesi. Tutti gli indizi farebbero pensare a un colpo di testa di Jacqueline, gelosa della sorella minore che non aveva mai potuto sopportare. Il problema è che Micetta si rifiuta di parlare, non risponde alle domande, non accetta interrogatori, non fornisce nessuna ragione del suo gesto scriteriato. Chiede soltanto che il marito le porti in carcere alcuni abiti, i ricambi di biancheria e gli effetti personali, ma senza il permesso di incontrarsi con lei. Non vuole più vederlo se non, obbligatoriamente, alla celebrazione del processo.
Alain non è affatto sconvolto, ama sua moglie senza passione, come una persona che gli appartiene per consuetudine, non diversamente dalle altre donne che gli si offrono e a cui non rinuncia. Perché dovrebbe. Neanche ora che la vita lo mette di fronte a un guaio non da poco, tale da compromettere tutto il suo castello di carte. I giornalisti assediano la strada della sua abitazione e lui, al solito, con la consueta aria da sbruffone, li fa salire in massa nell’appartamento, riempiendoli e riempiendosi di chiacchiere e alcool fino a tarda ora, in un indecente bivacco. La vecchia domestica, di fronte a quella tragedia, si è licenziata, disgustata; la portiera dello stabile gliene procura subito una nuova, Mina, che inizia il lavoro già la mattina dopo, cercando di rimettere ordine nel salone, e aspettando che lui si svegli per portargli caffè e croissant come le hanno riferito di fare. Sculettando. È una ragazza giovane, di appena ventidue anni, formosetta e provocante, che indossa ben poco sotto il grembiule. Ad Alain viene istintivo farci un pensierino, e lei sarebbe già pronta. La sbronza violenta lo scoraggia, è troppo malmesso, ma la mattina seguente Mina gli entra nel letto e lui ci fa l’amore con una delicatezza insospettabile per un predatore seriale: “La attirò a sé per baciarla, un bacio lungo e tenero, che non si rivolgeva necessariamente a lei. Non era rivolto neanche a Micetta e tanto meno ad Adrienne, non era rivolto a nessuna donna in particolare”.
Perché no, cosa c’è di strano. Naturalmente non pende alcuna accusa su di lui, nessun reato può essergli imputato. Tuttavia dal tragico evento non potrà sfuggire scuotendoselo semplicemente di dosso, come gli garba. Il giornale ne risentirà, il suo pubblico gli volterà le spalle giudicandolo un individuo dal comportamento amorale. Per difendere la moglie viene assunto il più famoso e abile penalista del Foro di Parigi, il quale non farà sconti a nessuno pur di assistere da par suo, e possibilmente riuscire a far assolvere l’assassina, calpestando ogni altro sentimento. Come uscirà Alain dalla brutta partita?
Va da sé che il seguito non è rivelabile, poiché come in ogni giallo che si rispetti anche nel nostro caso la conclusione di La Prigione, appena uscito da Adelphi, è del tutto inaspettata, e bisogna godersela incollati alle pagine del grande Sim.
Però ci si chiede: come può aver fatto uno scrittore del secolo scorso, pur immenso come Georges Simenon, a scrivere nel 1968 una vicenda che sembra ambientata ai nostri giorni, ritrae fedelmente nel protagonista la mutazione antropologica che ha sovvertito le nostre esistenze nell’ultimo mezzo secolo? Il miracolo dei grandi artisti, è ben noto, consiste nell’immaginare storie senza tempo, quasi indipendenti dal periodo storico in cui si svolgono. Forse perché la natura umana resta sempre uguale a sé stessa, e il panorama si adatta mimeticamente alle trasformazioni. Come i paesaggi dei grandi pittori del Quattrocento, in cui ognuno può credere di rinvenire scorci familiari della propria regione, della propria terra.
Ma il vero miracolo è ancora un altro, e cioè la sensazione di star assistendo a un sogno. Simenon suggerisce l’impressione di scrivere in uno stato di trance, di lucido dormiveglia. Credo sia stata questa la prerogativa per cui Fellini avvertiva lo scrittore belga così vicino a sé, al punto da considerarlo una sorta di fratello maggiore. L’inventore di Maigret, nella sua poderosa autobiografia ‘Memorie Intime’, accenna spesso a questa medesima inconsapevolezza; quando racconta per esempio la rapidità con cui scriveva i suoi leggendari polizieschi. Le indagini del celebre commissario – e sono settantacinque, senza contare i racconti! – venivano stese sulla carta, a matita, in appena un paio di settimane; un fenomeno, si direbbe, di scrittura automatica. Che sia questo il segreto dei grandissimi artisti, di creare sotto dettatura?