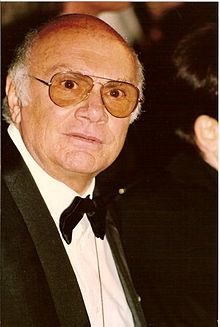Fine corsa in sordina, distacco da quella specie di fil-rouge o cordone ombelicale che resisteva, in molti di noi, come orgoglioso ricordo di altre stagioni (anni sessanta\settanta) del cinema autoriale, del comune sentire di una generazione non-riconciliata. Francesco Rosi, Anita Ekberg, Virna Lisi: tre congedi emblematici, emotivamente sofferti (nonostante la fredda parabola delle età anagrafiche), tra fine dicembre e inizi di gennaio, hanno concretamente certificato il nostro lungo addio con una certa idea di cinema (migliore di quella in corso) iniziata lo scorso anno con la scomparsa di Damiano Damiani- da tempo ammalato- e l’autodeterminazione al ‘distacco della spina’ di Carlo Lizzani: maestri di competenza, passione politica, battaglia delle idee. Quali? Quali modelli di elaborazione filmica non più ripetibili? Quelli di un cinema ubìquo, consentaneo alla centralità e alla sussidiarietà (in senso didattico, analiticamente problematico) del dibattito culturale ed all’immaginario collettivo di un Paese che, negli ultimi trent’anni, si è come narcotizzato alle sorgenti dell’oblio consumistico e del gusto ‘degradato’ agli stilemi dell’abulia ‘usa e getta’: televisiva,finto- ludica, ir-relazionale.
Con la morte di Francesco Rosi si completa infatti un ciclo ‘lunghi addii’ al mondo di ieri e ieri l’altro, alla cultura fibrillante, fertile, passionale dell’Italia rialzatasi (tra mille compromessi e contraddizioni) dalle macerie del dopoguerra, avente nel cinema il suo fulcro di (controversa) identità e (tribolata) egemonia dell’ alfabetizzazione al ‘racconto’, alla ‘narrazione’ (presente o evocativa) di un tessuto sociale del tutto iniquo, sbrindellato, disomogeneo per privilegi di classe e dislocazione geopolitica. Potremmo elencare le perdite pregresse non rimpiazzabili (da Fellini a Monicelli, da Risi a Gassman, Mastroianni, Manfredi, Tognazzi) oppure consolarci con eccellenti ‘sopravvissuti’ del tempo andato, ancora attivi e vegeti, ma in diversi contesti di ruoli e prestigio (penso a Stefania Sandrelli, a Lina Wertmuller, alla ‘reliquia’ di Monica Vitti -purtroppo ‘assente a se stessa’ da tanto tempo). Ma sarebbe una pratica di commemorazione e auto-afflizione del tutto sterile, fine a se stessa.
Preferibile invece concentrarsi su Rosi quale modello unico e geniale di un utilizzo del cinema derivante da una sua elaborazione alla stregua di ‘vedetta civile’, di ‘investigazione’ di un reale artatamente opaco, ambiguo, corroso dagli in-gaudiosi misteri del mantenimento del Potere ad ogni costo, correlato all’ignoranza, al depistaggio, alle distrazioni di massa di un popolo che, parafrasando Giovanni Sartori, ‘fa gioco tenere al giogo e trattare da bue’. Contro cui si scaglia la sete di conoscenza, disvelamento, accusa non sommaria di Francesco Rosi, il cui “Salvatore Giuliano” (1962) è caposaldo di una cinematografia d’inchiesta che si radicalizza nel disagio sociale adoperato come arma di ricatto, servilismo, estorta ‘disattenzione’. Del picciotto di Montelepre, di certo ‘si sa solo che è morto’. Ma , nella scomposizione e ricostruzione, mediante flash back e mixaggio tra fiction e documentario (con un pittorico uso del bianco e nero che si ispira ad Ejzenstejn , in virtù della fotografia di Di Venanzo, distillato su tre cromature esplicanti ogni sequenza: dalla sovresposizione del reportage in finta ‘presa diretta’ alla lirica tragicità dei chiaroscuri evocativi, al ‘grigio televisivo’ del processo di Viterbo) , Rosi indaga su un Paese malato di labirintite per la mancanza di equilibri ed equidistanze (costituzionali e non) sventrati già in epoca democristiana; dunque un Paese vessato e immiserito dalla con-sostanza di politica-finanza-malavita organizzata, regredito moralmente, inebetito da cesarismo ciarlatano e ‘benessere’ da mercimonio. Brucato fuori e bacato dentro. Di qui, per Rosi, la ricerca senza requie delle verità negate da ‘muri di gomma’ come scatole cinesi, di un’ ipotetica Italia redimibile che invoglia a compensare con l’ ‘intellegibile intuizione’ del cinema le voragini della realtà mistificata (per decenni o per secoli?).
“Il più grande narratore, indagatore per immagini del meridione italiano” (a giudizio di varie fanti) è del resto autore delle opere più coraggiose, paradigmatiche, da ‘manuale’ che informano la necessità di indagine e rivelazione che dà impronta alla coscienza civile successiva alla stagione del neorealismo. E soprattutto adattata ai famelici rampantismi di un ‘sud d’Europa’ segnato da ribalderie, familismo, connivenze volontarie o estorte. L’impegno a ‘capire’ e tentare di spiegare il ‘perché’ socio-antropologico di tanto degrado era iniziato, per Francesco Rosi (già assistente di Luchino Visconti per “La terra trema”) con “La sfida” (1957), film permeato di sensibilità umana e ambientale (Napoli, l’ascesa di un camorrista) che già si segnala per il perfetto dosaggio di habitat, paesaggio umano e distillata affluenza di quegli elementi ‘avvincenti, spettacolari’, la cui parsimoniosa, scabra efficacia sarà ‘stile’ e ‘sostanza’ di tutta l’opera di Rosi. Da “La mani sulla città” a “Il caso Mattei”, da “I magliari” a “Cadaveri eccellenti”, sino all’approdo (negli anni ottanta) ad un cinema di evocante indignazione antibellica (“Uomini contro” dal romanzo di Lussu, primo atto d’accusa contro la logica dell’interventismo e la retorica patriottarda che condussero allo sterminio della prima guerra mondiale). E di derivazione letteraria ben emulsionata nel passaggio dalla scrittura su pagina bianca al mosaico (elaborato ma non sofisticato) di costrutto filmico parsimonioso e di forte ispirazione umanitaria : come sarà per “Cronaca di una morte annunciata” dal libro di Garcia Marquez, preceduto (nel 1967) da quel dimenticato “C’era una volta”, con Sophia Loren ed Omar Charif, fabula e piacere fantastico appassionano alle vicende di una contadina meridionale che si innamora di un principe spagnolo e che “cerca di farlo suo con stregonerie e l’aiuto di santi”.
“Sottomettendo” la macchina da presa alla sua esigenze di narrazione e “facendo dell’Italia la nemica giurata di sé stessa” (cito Fabio Secchi Frau), il cinema di (e con) Rosi si sente libero, di agire, dibattere, divulgare, proporre tesi e per esse combattere, intuendo le potenzialità non divistiche di un certo tipo di contributo attorale (i grandi volti di quel cinema che fu ‘anche’ di Gian Maria Volonté, Philippe Noiret, Lino Ventura), che trae alimento dalle capacità autocritiche e straneazione sottilmente grottesca mutuate dal teatro brechtiano. Teatro cui Francesco Rosi, dopo il prezioso apprendistato giovanile, ritorna da metteur –en- scene ‘pensante e non illustrativo’ – in particolare con alcune commedie del repertorio di Eduardo, che il figlio Luca De Filippo gli affida a scatola chiusa (“Napoli milionaria”, “Le voci di dentro”, “Filumena Marturano”). Molte le rivincite della terza età , suffragate dal ritorno al cinema con “La tregua” (1997), sceneggiato con Rulli e Petraglia: l’Orso d’Oro alla carriera al Festival di Berlino del 2008,la Legion d’Onore della repubblica francese, il Leone d’Oro (ancora alla carriera) in occasione della 69° edizione della Mostra di Venezia del 2012. Poi la scomparsa (in tragiche circostanze) della moglie, la ricerca del ‘buon ritiro’ adeguato alla sua indole gioviale, conversevole, mai altezzosa. E, a ridosso dello scorso Natale, il silenziosi congedo di ultranovantenne ancora vigile, attivo nell’arduo agone civico-culturale di un Paese agli sgoccioli.
****
Grande illusione o ‘italian dream’ privo di fondamenta, gli anni migliori (e comunque ruggenti) del cinema italiano – della contigua sbornia collettiva cagionata da narcosi di benessere- potrebbero paragonarsi alla maschera mitologica di Giano bifronte . Di cui Anita Ekberh e Virna Lisi, così diverse, smaglianti, bionde ‘ultraterrene’ furono le visioni contrapposte ma complementari. L’opulenza di Anita, musa mai infranta de “La dolce vita” narrava di un’opulenza vichinga per noi stratosferica, paranormale, inaccessibile come illusione e tentazione a varcare le Colonne d’Ercole della perdizione senza ritorno. Esattamente come l ancora Fellini la volle scatenante “Le tentazioni del dottor Antionio” (con Peppino De Filippo in un ruolo cucitogli addosso) nel più delizioso degli episodi di “Boccaccio 70”. Come a fustigare e deridere tutti noi, ‘gens mediterranea’, dai gusti (e fobie) atrocemente provinciali ma sessualmente ‘diseducati’, quindi famelici, come i bambini e la marmellata.
Più icona che attrice, attimo fuggente di un immaginario collettivo sempre più frastornato e alle prese con le morse della ‘sopravvivenza competitiva’, la Ekberg non superò i ‘demoni e dei’ dell’idolatria a breve termine (assegnatagli dalla breve fama felliniana) galleggiando per mediocri titoli hollywoodiani (“Chiamami Buana”, “Bianco, rosso, giallo, rosa”, “Stazione Luna”), appena riscattati dalla partecipazione, nel ruolo di se stessa, all’”Intervista” del devoto (e palesemente innamorato) amico Federico, nell’episodio in cui- accompagnato da Marcello Mastroianni- il riminese si reca ad omaggiarla nella sua ultima dimora ai Castelli Romani. Che Anita, di lì a poco, fu costretta a svendere (per debiti pregressi) e facendo perdere ogni traccia di quel ‘suo passaggio’ che, quarant’anni prima, risuscitava i morti. Mai nessuno che sia andato a cercarla.
Mentre Virna Lisi, eburnea ed eterea nella carnagione alabastro della prima giovinezza, ‘venere’ dagli occhi azzurri di una bellezza generosa e finto-angelica (che incuteva soggezione ai più grande partner di arte e di vita) seppe re-iventare se stessa alla fine della ‘prova’ americana, ove molti tycoon speravano di farne un’altra Monroe, con film di discreta o buona caratura quali “Come uccidere vostra moglie” di Quine, “Eva” di Losey,”La venticinquesima ora” di Verneuil. Tornata in Italia senza rimpianti (“fu piuttosto una liberazione”), da intelligente, pragmatica ragazza borghese, scelse di dedicarsi alla famiglia, al marito ed al figlio appena nato. Dimezzando gli impegni professionali per tutto il corso degli anni settanta (con il perfetto cammeo della trasognata cassiera in “Signore e signori” di Germi) , Virna Lisi tornò a lavorare a ritmi più sostenuti con l’inizio del successivo decennio.
Dimostrando grande maturità, saggezza di discernimento, notevole capacità d’interprete (dai registri leggeri a quelli drammatici) con ruoli più impegnativi: dunque partecipando (e lasciando la sua volitiva impronta) in “Al di là del bene e del male” (1977) di Liliana Cavani, “Ernesto” (1979) di Salvatore Samperi , “La cicala” (1980) di Alberto Lattuada. Interpreterà in seguito una seducente madre in vacanza nella commedia nostalgica “Sapore di mare” (1983) di Carlo Vanzina (regista con cui lavora anche l’anno successivo in “Amarsi un po’…”) ed entrerà a far parte del cast de “ I ragazzi di via Panisperna” (1988) di Gianni Amelio e di “Buon Natale, buon anno” (1989) di Luigi Comencini.
La ‘consacrazione’ arriverà con i numerosi riconoscimenti della terza età , tra i quali spiccano la Parla d’oro al Festival di Cannes, assegnatole per il ruolo di Caterina de’ Medici in “La regina Margot “(1994) di Patrice Chéreau e il David di Donatello alla Carriera . Con il nuovo millennio, Virna Lisi riprenderà l’attività televisiva dei suoi esordi : nelle fiction “Uno di noi” (1996), “Cristallo di rocca” (1999), “Le ali della vita” (2000), “Il bello delle donne” (2001) e soprattutto in “Caterina e le sue figlie” , distribuito in tre stagioni di buon successo, dal 2005 al 2010).In cui indosserà gli ‘abiti’, divenuti consueti, di madre in ambascia alle prese con i guai delle figlie. Signora di ineccepibile, sobria, ma non più algida avvenenza sino all’ultimo ciak.