Giuliana Tedeschi (Milano, 9 aprile 1914-Torino, 28 giugno 2010), nata Fiorentino, milanese di nascita, si trasferisce a Torino in occasione del matrimonio con Giorgio Tedeschi, architetto originario del capoluogo piemontese, del quale adotterà il cognome. Di famiglia ebraica, trascorre l’infanzia a Napoli, dove il padre si era trasferito per lavoro, quindi torna a Milano, dove si laurea con una tesi in glottologia con Benvenuto Terracini per poi approdare definitivamente a Torino. L’emanazione delle leggi razziali fasciste del 1938 le preclude l’accesso all’insegnamento. Nel 1940 nasce la prima figlia e pochi anni dopo la seconda, finché l’8 marzo 1944 viene arrestata con il marito e la suocera, mentre le due bambine, Rossella ed Erika (questa seconda sposerà Guido Ceronetti), vengono messe fortunosamente in salvo dalla domestica. I tre sono condotti in carcere, quindi nel campo di Fossoli e da lì, il 5 aprile 1944, deportati ad Auschwitz con altre seicento persone. La suocera viene immediatamente eliminata nella camera a gas, mentre Giorgio e Giuliana vengono separati. Giorgio morirà il 25 gennaio 1945 durante la marcia di evacuazione da Auschwitz: Giuliana lascerà il campo il 18 gennaio dello stesso 1945, con una marcia di evacuazione da Ravensbrück, quindi sarà trasportata a Malchow, infine liberata da russi e francesi. Ricongiunta finalmente alle figlie, nel 1946 pubblica Questo povero corpo (Editrice Italiana Milano, riedito dalle Edizioni dell’Orso, Alessandria 2005), uno dei primi esempi di testimonianza femminile sulla condizione delle donne internate nei campi di prigionia.
Personalmente ho avuto la fortuna di conoscere Giuliana Tedeschi come docente di materie letterarie nei due anni del ginnasio (1964/1966), presso il Liceo Vincenzo Gioberti di Torino, un istituto scolastico che ha vantato insegnanti di notevole levatura intellettuale e notorietà. Nella sezione C, che era quella nella quale ero stata inserita, insegnava nel triennio superiore Lidia De Federicis, coautrice dei numerosi volumi di storia e critica della letteratura Il materiale e l’immaginario, cofondatrice dell’Indice dei Libri del mese e impegnata per la laicità nella scuola. L’altro insegnante di punta era Albino Galvano, pittore e titolare della cattedra di storia e filosofia, che nella seconda metà degli anni Sessanta ci aprì al mondo – è proprio il caso di dirlo – della psicoanalisi. La prima condivise con noi il Sessantotto (di cui il Liceo Gioberti fu infuocato pioniere), il secondo non risparmiò ironie al riguardo. Erano anni di grandi cambiamenti che investivano i metodi didattici e le relazioni tra docenti e studenti, ed è in quel contesto che conobbi “la Tedeschi”, come la chiamavamo noi, altro riferimento fondamentale all’interno del Liceo e della mia vita e riferimento importante per generazioni di studenti come insegnante di italiano, latino e greco e come autrice di libri di testo, grammatiche e sintassi relative alle sue materie di insegnamento.
Indimenticabile è stato l’incontro con lei: nella prima ora di storia si presentò in classe e ci raccontò la Shoah, a partire da sé. Non ci fu bisogno di molte parole: si rimboccò la manica – mi pare la sinistra – della camicetta e con una semplicità del tutto priva di enfasi ci mostrò il numero impresso sul suo braccio: 76847. Ci parlò delle leggi razziali che dal 1938 le avevano impedito di insegnare, nonostante avesse superato il concorso, e ci illustrò brevemente e pacatamente – colpì tutte e tutti noi la sua serenità – il trasferimento ad Auschwitz e tutto il resto cui andarono incontro lei in quanto ebrea e numerose altre sue compagne e compagni. Additò poi l’armadio che stava in fondo all’aula, la “bibliotechina di classe” – come lei stessa la chiamava: “Lì trovate alcune copie di Se questo è un uomo di Primo Levi, vi consiglio di leggerlo”. E con un largo sorriso – sorrideva sovente Giuliana – avviò il programma scolastico, che quel primo anno prevedeva la storia degli Assiri e dei Babilonesi.
 Ripensando ora a quella mattina del primo giorno di scuola superiore, mi stupisco che Giuliana Tedeschi non avesse fatto cenno al suo primo libro Questo povero corpo (EDIT, Milano 1946, ora Edizioni dell’Orso, Alessandria 2005, presentazione di Anna Bravo, introduzione di Lucio Monaco) del quale non mi pare ci fosse traccia nella bibliotechina: è come se la “mia” professoressa, della quale ero molto orgogliosa, avesse deciso di destinare il proprio corpo alla presenza testimoniale della sua drammatica esperienza e non volesse aggiungervi altro. D’altra parte, finché visse, Giuliana Tedeschi fu molto attiva nel testimoniare pubblicamente la sua esperienza di deportata e sopravvissuta, attività parallela alla sua professione di insegnante.
Ripensando ora a quella mattina del primo giorno di scuola superiore, mi stupisco che Giuliana Tedeschi non avesse fatto cenno al suo primo libro Questo povero corpo (EDIT, Milano 1946, ora Edizioni dell’Orso, Alessandria 2005, presentazione di Anna Bravo, introduzione di Lucio Monaco) del quale non mi pare ci fosse traccia nella bibliotechina: è come se la “mia” professoressa, della quale ero molto orgogliosa, avesse deciso di destinare il proprio corpo alla presenza testimoniale della sua drammatica esperienza e non volesse aggiungervi altro. D’altra parte, finché visse, Giuliana Tedeschi fu molto attiva nel testimoniare pubblicamente la sua esperienza di deportata e sopravvissuta, attività parallela alla sua professione di insegnante.
Importantissimo il suo lascito, non solo culturale ma di vita: Giuliana ha da subito riconosciuto il valore di ciascuna e ciascuno indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza, cosa che per me e per il mio compagno di classe Marcello è stato importante, dato che eravamo gli unici figli di operai seduti in quei banchi abitati per lo più da figli e figlie di professionisti della borghesia torinese. Per di più ero l’unica femmina in quella classe (e, se ricordo bene, nell’intera scuola: Francesco, l’altro “proletario” di qualche anno più grande di noi, era appunto un maschio!), e con il suo esempio Giuliana mi ha trasmesso la consapevolezza – complice anche la ventata in arrivo dei maturi anni Sessanta – che le donne ce la possono fare. Se ce l’ha fatta lei a sopravvivere al lager, sicuramente io – ero infatti una secchiona – sarei riuscita nella mia “impresa” di liceale. Due percorsi certo imparagonabili, ma questo avevo annotato, in modo confuso e con un po’ di vergogna, nelle pagine del diario che tenevo in quegli anni.
Ed è a lei, alla “madre simbolica” che si è rivolto il mio pensiero quando, come referente della Società Italiana delle Letterate, nell’ambito della Commissione Comunale per la Toponomastica della città di Torino, ho inoltrato la richiesta di intitolarle un giardino in prossimità del quartiere in cui Giuliana visse prima di trasferirsi nella collina torinese. Accettata la proposta, attendiamo la posa della targa che la ricordi.
I suoi scritti non lasciano spazio alcuno all’invenzione, ma restituiscono il vissuto, e lo fanno fino alla liberazione: dall’“animo arido e silente” della detenzione allo scioglimento dell’emozione che “dapprima sopita, poi trattenuta, ritardata, dosata per paura, proruppe in lacrime e gemiti di gioia”. La citazione è tratta dalle pagine finali di C’è un punto della terra…Una donna nel Lager di Birkenau (prefazione di Alessandro Galante Garrone, Firenze, Giuntina, 2013), entrate nell’antologia, la più recente che io conosca, Nel buco nero di Auschwitz. Voci narrative sulla Shoah (Novara, Interlinea, 2021), a cura di Giovanni Tesio, che firma anche un’analoga antologia di componimenti in versi.
La fame e i bisogni del corpo sono sempre fatti risuonare, in Giuliana Tedeschi, con la dignità dell’essere umane: “La zuppa è servita in una sola gamella per cinque o sei persone: una brodaglia di rape gialle e stoppose, con qualche raro pezzo di patata e di carota. Sulla scodella comune le donne, sprovviste di cucchiaio, si curvano come cuccioli intorno ad una ciotola” (p. 15). E la tenerezza dei cuccioli sembra lì per lì attenuare la riduzione della persona ad animale. Ma poche righe dopo leggiamo che “ai gabinetti si va non per necessità individuale, ma in gruppo, accompagnate, secondo il capriccio della capoblocco” (ibidem), con le conseguenze facilmente immaginabili.
Del tutto rilevante mi pare il rapporto di Giuliana con l’immaginazione. La sua razionalità, che le permette di descrivere le peggiori angherie, le più mostruose e disumane situazioni con occhio lucido e asciutto, non concede spazio alla sublimazione immaginifica. Essendo la mancanza di cibo una costante delle condizioni delle prigioniere e dei prigionieri nei lager, capita con una certa frequenza di incontrare momenti in cui la fantasia interviene a confortare gli stomaci vuoti. Si pensi in particolare a Dacia Maraini, per la quale, nel ricordo di adulta, l’affabulazione infantile è stata sollievo dell’animo e l’immaginazione una potente tecnica per arginare i morsi della fame: “a volte ci si sfama anche con gli occhi” – scrive (Bagheria, Milano, Rizzoli, 2000, p. 12) – ricordando i giochi con le pietre, che la sua fantasia trasformava in pane, pasticcio di carote, banana, a seconda della struttura. Non così in Giuliana Tedeschi: all’opposto, la sua sensibilità si esaspera all’irruzione delle fantasticherie culinarie delle compagne.
Trasferita con altre nel campo di concentramento e transito di Malchow, “un paradiso” rispetto a Ravensbrück, ma dove non diversamente da prima “la fame è l’unica dominatrice”, la giovane donna ricorda l’aggressività che le suscitavano i “pranzi immaginari” sui quali si intrattenevano le compagne (p. 158). In una situazione in cui “la razione di pane è una fetta larga due dita”, la minestra si riduce ad acqua scondita “su cui galleggia qualche fetta di rapa” e talora si sta fino a “ventisei ore senza ingerire nulla” (pp. 157-158), si cerca di risparmiare energie, che viceversa si consumano ricordando i ravioli di carne, i filetti di sogliola o il roastbeef. È una forma patologica, una “psicomanzia”, che la fa urlare di rabbia, perché – dice – “quando parlate di cibi, mi prende un istinto di belva… Preferisco […] parlare di tubercolosi polmonare…” (p. 158). Meglio guardare in faccia la fame e la debolezza che “scheletrivano” piuttosto che una illusoria e falsa consolazione. (Per un discorso più approfondito al riguardo, cfr. Luisa Ricaldone, Tra le pagine della fame. Un viaggio letterario, Torino, SEB27, 2023, pp. 37-63).
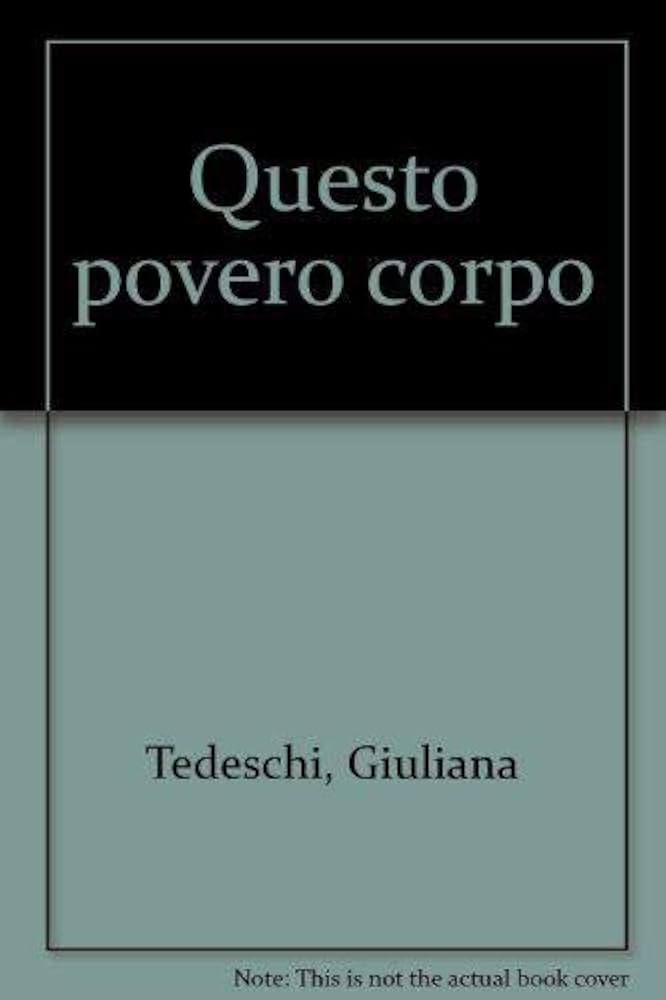 Altro tema sul quale la memorialistica dei lager non può, non deve, esimersi, è la descrizione dei corpi. Ed è appunto il corpo a dare il titolo allo scritto precocissimo di Giuliana Tedeschi, Questo povero corpo, citato prima. Scelgo due brevi passi tratti dalle prime pagine del volume, che esprimono in modo esemplare a che punto di devastazione è giunto l’“involucro” – come lei stessa definisce il corpo – la materia cui è appesa l’esistenza in vita. “Il concetto del corpo – scrive – sublime involucro dell’anima, rispettato e onorato come sede della scintilla divina sembrava un antico retaggio di concezioni religiose o filosofiche. Qui il corpo era solo spiato per constatarne l’aspetto miserando, per giustificare col disgusto e la ripugnanza la sua fine al crematorio” (ivi, p. 18). E ancora: “Se oggi analizziamo i sentimenti che la visione dei nostri corpi mi suscitò in momenti diversi, mi accorgo che non basta la parola «pietà» a riassumere quel complesso di sensazioni che provai. C’era un sentimento che la oltrepassava e che partendo da essa degenerava in disgusto e ripugnanza. Così le notti di disinfezione mensile quel mucchio di corpi nudi, sfiniti dalla lunga giornata di lavoro, dalle ore di attesa, estenuati dal digiuno, ammucchiati per terra l’uno sull’altro, cercando riposo e riparo dal freddo, in attesa che le vesti uscissero dall’autoclave, avevano l’aspetto di una immane miseria, ma al tempo stesso un senso di repulsione mi costringeva a rimanere a tremare desta e solitaria in un angolo” (ivi, p. 19).
Altro tema sul quale la memorialistica dei lager non può, non deve, esimersi, è la descrizione dei corpi. Ed è appunto il corpo a dare il titolo allo scritto precocissimo di Giuliana Tedeschi, Questo povero corpo, citato prima. Scelgo due brevi passi tratti dalle prime pagine del volume, che esprimono in modo esemplare a che punto di devastazione è giunto l’“involucro” – come lei stessa definisce il corpo – la materia cui è appesa l’esistenza in vita. “Il concetto del corpo – scrive – sublime involucro dell’anima, rispettato e onorato come sede della scintilla divina sembrava un antico retaggio di concezioni religiose o filosofiche. Qui il corpo era solo spiato per constatarne l’aspetto miserando, per giustificare col disgusto e la ripugnanza la sua fine al crematorio” (ivi, p. 18). E ancora: “Se oggi analizziamo i sentimenti che la visione dei nostri corpi mi suscitò in momenti diversi, mi accorgo che non basta la parola «pietà» a riassumere quel complesso di sensazioni che provai. C’era un sentimento che la oltrepassava e che partendo da essa degenerava in disgusto e ripugnanza. Così le notti di disinfezione mensile quel mucchio di corpi nudi, sfiniti dalla lunga giornata di lavoro, dalle ore di attesa, estenuati dal digiuno, ammucchiati per terra l’uno sull’altro, cercando riposo e riparo dal freddo, in attesa che le vesti uscissero dall’autoclave, avevano l’aspetto di una immane miseria, ma al tempo stesso un senso di repulsione mi costringeva a rimanere a tremare desta e solitaria in un angolo” (ivi, p. 19).
Negli anni immediatamente successivi alla fine del secondo conflitto mondiale, “la memorialistica dei Lager – scrive Anna Bravo nella presentazione del libro di cui sopra –, messa di fronte alle incredulità che cominciano a manifestarsi, reagisce con una volontà forte di certificazione, con la ricerca di un’esattezza e di un linguaggio quasi notarili; sebbene la soggettività trovi nonostante tutto parole per esprimersi, non viene rivendicata, e resterà a lungo fra parentesi. Giuliana la considera invece il cuore della storia; senza rinunciare all’affermazione della verità, mostra il contesto soggettivo in cui quell’affermazione ha preso forma, un contesto spesso immateriale, ma non per questo meno reale, che interseca la trama dei fatti, e a volte la sovrasta con la sua complessità. Per questo, leggere gli scritti di Giuliana, rileggerli, ascoltarla, è un viaggio che va fatto e ripetuto” (p. VII). E la storica astigiana, scomparsa a Torino nel 2019, individua nel legame stretto della forte razionalità con la sfera dell’emotività la componente distintiva rispetto ad analoghe testimonianze maschili, che – forse ad eccezione di Primo Levi – hanno visto nel corpo il “luogo della debolezza” e nella “vicinanza fisica con gli altri una minaccia alla propria identità, quasi un pericolo di sperdimento”. In Giuliana la razionalità è forte, “ma non trincerata né disincarnata […]. La consapevolezza di sé è acuta, ma riconosce appieno quanto l’identità deve al rapporto con gli altri” (p. VIII). “La vita delle prigioniere – scrive Tedeschi in C’è un punto della terra… Una donna nel Lager di Birkenau, p. 98) – è come una maglia i cui punti sono solidi se intrecciati l’uno all’altro; ma se il filo si recide, quel punto invisibile sfugge fra gli altri e si perde”.
L’interesse particolare per le donne, si manifesta in Questo povero corpo attraverso uno sguardo concentrato anche sulle “donne soldato”, questi “esseri innaturali” partoriti dalla Germania nazista, che si delineano accanto alla forca, dotata della figura gigantesca del “prigioniero” boia, “enorme – scrive – come nelle fiabe dei bimbi” (p. 81). Segue la descrizione dell’impiccagione di due polacche giovanissime, accusate di aver sabotato un crematorio, mentre una Aufseherin, una guardia del campo, che “accoppiava alla rigida uniforme mascolina un volto spietato, alieno da commozione e sentimenti femminei” minacciava un’amica delle vittime che singhiozzava di fronte alle due polacche che “offrirono il collo delicato al boia”. E Giuliana? “nel tragico silenzio che seguì udivo soltanto i miei denti battere con un rumore sinistro per lo choc e per il freddo” (pp. 82-83).

